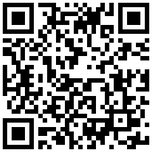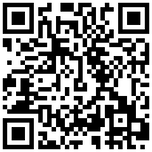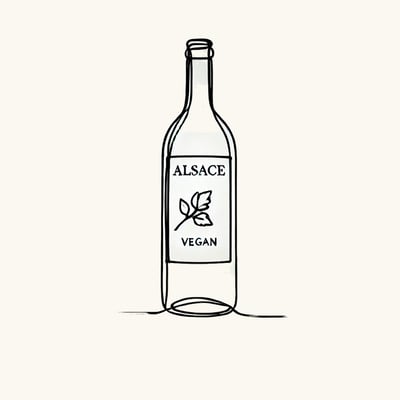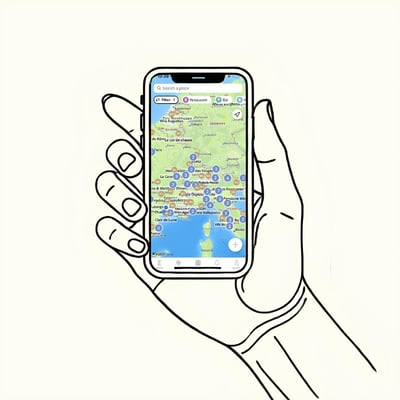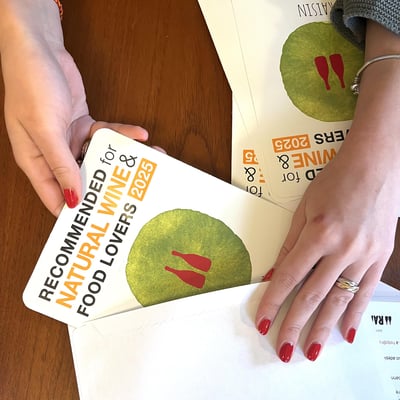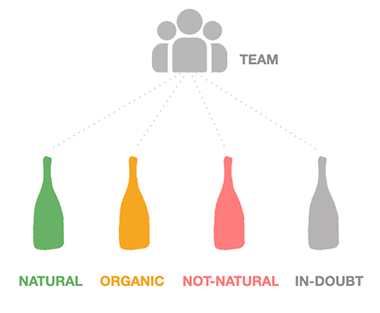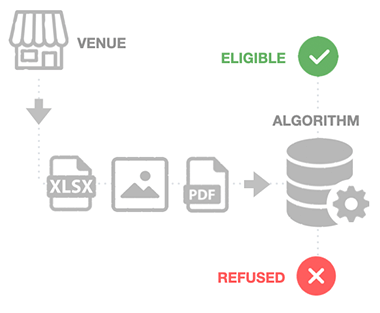Dicembre 12, 2024 - 1 Commenti
Didier Grappe: Il Jura in resistenza
Abbiamo intervistato Didier Grappe ed è stato appassionante! In un podcast di 20 minuti, Didier si apre con passione e autenticità, affrontando temi fondamentali come il vero valore del vino, la sfida del gelo, i vitigni ibridi, la magia dello Jura, i trattamenti e i solfiti, la selezione genetica, le AOC e l’importanza della trasmissione del sapere. Una conversazione che va dritta al cuore e lascia spazio a profonde riflessioni.
Disponibile su:
- Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/us/podcast/raisin-vin-naturel-gastronomie/id1784675196
- Spotify : https://open.spotify.com/show/1XQ5BgMAekl2zJ0qlrqXRO?si=mXkeUaLzSGuRedtuVHKb0g
- Deezer : https://deezer.page.link/rNUK11xQYae9tmm79
Di seguito troverai la trascrizione del podcast con Didier Grappe.
All'inizio hai avuto difficoltà a trovare sbocchi commerciali e a vendere i tuoi vini?
"Ho iniziato nel 2000 e ho vissuto un periodo in cui i vini dello Jura non erano affatto apprezzati. Venivano considerati acidi, ossidativi, e nessuno li voleva bere. All’epoca, questi vini si consumavano solo nello Jura, e soltanto la genti di qui li apprezzavano. Oggi, invece, il mondo intero desidera bere Jura. Siamo arrivati al punto in cui persino una crêperie a Copenaghen offre quattro etichette dello Jura. È incredibile: siamo minuscoli, rappresentiamo solo lo 0,3% del territorio viticolo francese, ma c’è una domanda enorme. Siamo fortunati. Tuttavia, ci sono realtà diverse: ho colleghi nella Loira che vendono bottiglie a 7-8 euro, un prezzo che non rende giustizia al loro valore. Quelle bottiglie dovrebbero costare almeno 25 euro, ma sono schiacciati da un mercato molto più ampio."

Qual è la tua opinione sui prezzi del vino attualmente?
Noi puntiamo a mantenere prezzi accessibili. Per esempio, abbiamo un Savagnin ouillé a 12 euro, e credo che siamo tra i più economici della regione per i vini senza solfiti. Lavorare a livello locale e offrire prezzi popolari è fondamentale per noi. Vogliamo restare vicini al mercato europeo e mantenere questa filosofia. Personalmente, quando vado in un'enoteca e trovo un ricarico di 2-2,5 volte, apprezzo poter acquistare una buona bottiglia a 20 o 25 euro. Con 25 euro hai una bottiglia di qualità, hai speso il giusto per goderti un momento conviviale. Le bottiglie da 60 euro? Quelle le riservo per occasioni speciali e per ottimi amici attorno al tavolo. Dove si vede davvero speculazione è nelle aziende che producono quantità molto limitate. È il classico gioco della domanda e dell'offerta: ci sarà sempre qualcuno disposto a pagare 300, 400 o 500 euro per una bottiglia esclusiva, ma per noi è importante restare con i piedi per terra.
Come è andato questa annata?
"Abbiamo già affrontato delle gelate e perso due terzi del raccolto. È ancora presto per avere una stima precisa: la perdita potrebbe arrivare al 60% o addirittura all’80%, ma al momento non possiamo esserne certi. Ci sono germogli che stanno ricrescendo e potrebbero produrre qualche frutto. Inoltre, abbiamo varietà ibride che rifioriscono e riescono a fruttificare anche dopo una gelata. Per ora, la situazione rimane incerta, ne sapremo di più tra una quindicina di giorni. Certo, il danno è significativo, ma bisogna dire che abbiamo avuto due annate straordinarie, il 2022 e il 2023. Se consideriamo la media di tre anni, anche con un terzo del raccolto, riusciamo a cavarcela. Detto questo, è un anno davvero complicato. La primavera, ad esempio, è stata incessantemente piovosa: pioggia, pioggia e ancora pioggia."

Come hai iniziato a lavorare nel mondo del vino?
Ho iniziato aiutando il mio vicino, che era un viticoltore. Nei fine settimana andavo a lavorare da lui; purtroppo oggi non c'è più. Successivamente ho avviato la mia attività con le prime vigne di proprietà. Ho deciso poi di proseguire gli studi e ho conseguito il diploma agricolo. Questo mi ha permesso di stabilirmi definitivamente e di recuperare numerosi terreni vergini e incolti. Si tratta di terreni straordinari, rimasti senza viti per oltre 80 anni, riposati e privi di tracce di pesticidi. Una base perfetta per iniziare.
Vent'anni fa era molto più conveniente acquistare terreni qui, nello Jura, rispetto a oggi?
Oggi la situazione è diventata complessa, soprattutto ad Arbois, dove c’è un’enorme pressione fondiaria. Appena si libera un appezzamento di vigneto, si fanno avanti 150 persone interessate. Ma per me, all’epoca, era tutto più semplice. Mi offrivano vigneti regolarmente: a volte rifiutavo, altre volte accettavo. Ho potuto comprare i terreni che desideravo. Vent'anni fa era davvero facile. Oggi, invece, i giovani si ritrovano ad acquistare solo vecchi appezzamenti, logorati fino all’osso, difficili da meccanizzare e con una bassa resa.
Ho tre parcelle qui nel comune, e questa è la più grande. Vedo le vigne direttamente dalla mia cantina, ed è davvero comodo durante la vendemmia. Fa davvero la differenza, perché posso capire subito se devo lasciare il torchio chiuso o meno, a seconda di come lavorano i vendemmiatori! Se vedo che fanno un ulteriore passaggio, lo lascio chiuso. La città più lontana è a un chilometro. Per trasportare l'uva o andare a lavorare, ci muoviamo in bicicletta o a piedi.

Conservi qualche bottiglia dei tuoi vini?
Un po’, sì, ma non tante. Mi appassionano di più le nuove cuvée rispetto a quelle più vecchie. Però Jules, mio figlio e socio, vorrebbe farlo. Devo ammettere che, quando accogliamo ospiti importanti, è piacevole poter stappare cuvée più vecchie.
Qual è stato il ruolo dei vitigni ibridi nello Jura?
Negli anni ’50, Pierre Overnoy ricorda che un terzo dei vigneti francesi fosse piantato con vitigni ibridi, si trovavano dappertutto nella campagna. Ha anche ricordi di un vino quotidiano. A Pupillin, ad esempio, la transizione alle AOC avvenne rapidamente, portando allo sradicamento immediato degli ibridi. Nel sud del Jura, invece, questi vitigni erano ancora molto diffusi, soprattutto tra i contadini che praticavano un’agricoltura diversificata. Il modello tipico era semplice: una decina di mucche, un ettaro di vigna, qualche albero da frutto. Erano pochissimi quelli che producevano solo vino, forse una decina di famiglie in tutto lo Jura. Gli altri erano agricoltori a tutto tondo, con una stalla, un granaio e una piccola cantina. Coltivavano un orto, allevavano quattro mucche e gestivano pochi filari di vigna.
In questo contesto, i vitigni ibridi si rivelavano perfetti: non richiedevano trattamenti e, durante la fienagione, la vigna poteva essere trascurata senza troppi problemi. Ma con l’introduzione delle AOC, l’uso di questi vitigni fu vietato, segnando una svolta radicale. Oggi, i vitigni ibridi sono praticamente scomparsi dalla Francia. È difficile immaginare che un tempo coprissero un terzo dei vigneti, pari a 400.000 ettari, la metà dell’attuale superficie vitata, che oggi si aggira intorno agli 800.000 ettari.
Sono state avviate campagne di denigrazione e offerti incentivi per l’estirpazione delle vigne. Alla fine, l’adeguamento alle AOC è diventato obbligatorio. I contadini, che un tempo possedevano sia vigneti che allevamenti di bestiame, hanno finito per ampliare le loro attività agricole, specializzandosi in un’unica direzione: viticoltura o allevamento. Di conseguenza, quel modello agricolo misto è andato perduto.
Negli anni '50, il settore vinicolo affrontò una grave crisi di sovrapproduzione. I vigneti del Maghreb, che fino a poco tempo prima non esistevano, iniziarono a produrre vino, mentre in Francia erano ancora presenti 400.000 ettari coltivati con vitigni ibridi. Contemporaneamente, il consumo di vino diminuì drasticamente, causando un eccesso di produzione e un conseguente crollo dei prezzi.
Per affrontare questa situazione, furono adottate due principali soluzioni. La prima fu ridurre il limite massimo di acidità volatile consentita (da 1,6 o 1,2 a 0,88), una misura che penalizzò i vini del Maghreb, naturalmente più con più volatile a causa del clima caldo. La seconda fu vietare l'uso dei vitigni ibridi nelle denominazioni di origine controllata (AOC), incentivando la loro estirpazione e spingendo i contadini ad abbandonare la viticoltura, lasciandola ai vignaioli professionisti.

Queste misure erano una diretta conseguenza della crisi di sovrapproduzione. In passato, il vino veniva consumato in quantità maggiori, ma con il calo dei consumi ogni regione esercitò pressioni sui propri rappresentanti politici per ottenere leggi che vietassero gli ibridi. Queste leggi furono accompagnate da campagne diffamatorie, che li descrivevano come non qualitativi. All’epoca, considerazioni ecologiche o di sostenibilità non avevano alcun peso nel dibattito.
Quando ero a Beaune nel 1999 e parlavo di ibridi, mi dicevano che la peronospora e l’oidio erano problemi minori, facilmente trattabili. Mi chiedevo perché non si usassero piante resistenti all’oidio, visto che in certe annate, anche con 15 trattamenti, alcune regioni non riuscivano comunque a raccogliere. Eppure, si ostinavano a sostenere che fosse un problema trascurabile. Ma quando vedo tutte queste falde freatiche inquinate dai trattamenti…
Valentin Morel descrive le viti coltivate oggi come malati cronici in cure palliative, sottoposti a trattamenti continui per sopravvivere. Una vite convenzionale, se non viene trattata per 4-5 anni, non ce la fa: non riesce a fare abbastanza fotosintesi, si indebolisce e muore. Al contrario, esistono portainnesti o ibridi che crescono rigogliosi nei boschi, producendo uva in abbondanza senza alcun intervento. Tuttavia, i nostri vitigni tradizionali, come Chardonnay e Poulsard, se non trattati per 3-4 anni, soccombono. È come se fossero pazienti dipendenti da una flebo continua di prodotti fitosanitari.
In passato, però, esistevano varietà che non richiedevano nulla. Con Valentin Morel, Yves Roy e altri colleghi del Jura e del Beaujolais, abbiamo deciso di reintrodurre questi vitigni per produrre vino naturale, senza alcun trattamento, né in vigna né in cantina. I nostri ibridi non necessitano di interventi. Se mai dovessero presentare malattie, forse interverremmo, ma finora non abbiamo visto nulla di simile. Sono varietà resistenti da oltre un secolo, che continuano a prosperare. Anche in anni di forte pressione della peronospora, i nostri ibridi si sono dimostrati dieci volte più resistenti dello Chardonnay trattato otto volte. Sono semplicemente straordinari, garantendo raccolti abbondanti senza perdite.
In passato, lo Jura vantava centinaia di vitigni diversi. I vini venivano prodotti senza l’aggiunta di solfiti e senza l’uso di lieviti selezionati: questa era la vera tradizione. Oggi, però, ci viene presentato come "tradizionale" il vino tecnologico degli anni ’70, ma non è così. Un tempo esisteva una straordinaria diversità, con cloni differenti e assemblaggi di bianchi e rossi. Quella era la tradizione: vini liberi. Oggi, invece, si è scelto di omologare tutto.
Riesci a riconoscere i vini prodotti da vitigni ibridi durante una degustazione alla cieca?
Per i rossi, direi di sì: sono spesso abbastanza riconoscibili. Li adoro, ma tendono ad avere un profilo fruttato fresco, quasi selvatico, a volte con una leggera nota acquosa. A metà palato, capita che perdano un po' di struttura. Li apprezzo molto, ma sì, riesco a distinguerli. I bianchi, invece, sono tutta un’altra storia. Alla cieca, è davvero complicato identificarli. Confondere un Chenin con un Savagnin, ad esempio, sarebbe facilissimo.
Puoi parlarci delle tue viti ibride?
"Ho piantato le mie viti ibride otto anni fa, e ne abbiamo ripiantate altre circa quattro o cinque anni fa. Tuttavia, anche la vigna di quattro anni ha sofferto a causa della siccità: alcuni acini si sono avvizziti. Abbiamo fatto una selezione, ma volutamente ne abbiamo lasciati alcuni. Ritengo che siano stati proprio questi acini a conferire al vino quella tensione acida che, alla fine, si armonizza perfettamente.
Gli ibridi hanno un grande vantaggio: sono in grado di rifiorire e produrre nuovi frutti anche dopo una gelata. I contro-gemogli risultano produttivi. Negli ultimi anni abbiamo affrontato gelate nel 2017, 2019, 2021 e 2024. Forse ora ci aspettano 25 anni senza gelate, ma recentemente abbiamo vissuto una serie davvero terribile.
Ci sono molte soluzioni estreme per fronteggiare le gelate: fili riscaldanti, stufe a gasolio, pale eoliche alimentate da bruciatori a gasolio o persino elicotteri per mescolare l’aria. È davvero assurdo dover ricorrere a bruciare paglia, legna o altri materiali solo per riscaldare le nuvole e salvare pochi germogli. Personalmente, non mi sento in sintonia con questo tipo di agricoltura.
Dobbiamo smettere di estrarre fossili dal suolo e utilizzare combustibili fossili per proteggere tre germogli. Non ha senso riscaldare le nuvole con dispositivi che emettono fumo nero. A un certo punto, è necessario trovare alternative più sostenibili, e i vitigni ibridi rappresentano una di queste. Rifioriscono e continuano a produrre frutti.
Valentin Morel, ad esempio, nel 2019 ha perso tutte le sue vigne tradizionali a causa delle gelate, ma grazie agli ibridi è riuscito comunque a ottenere 30 ettolitri per ettaro. Nonostante un raccolto ridotto, è stato comunque soddisfacente, e tutto questo senza bruciare carbonio.
Per questo promuoviamo apertamente questi vitigni: dal nostro punto di vista, offrono solo vantaggi."
Associazione Vitis Batardus Liberata
Esiste oggi un’associazione chiamata Vitis Batardus Liberata, che riunisce gli appassionati di vitigni ibridi naturali. Siamo circa una trentina di vignaioli: nello Jura ci sono Valentin Morel, io, Yves Roy; nel Beaujolais, Hervé Ravera, Romain des Grottes, Geoffrey Estienne, e tanti altri, tra cui Nadia Beaune.
L’obiettivo principale dell’associazione è promuovere questi vitigni, diffondere la conoscenza tra i vignaioli e incoraggiarli a coltivarli. Ne parliamo con la stampa, i sommelier e il pubblico, ma per me il vero cuore del progetto è collaborare direttamente con i viticoltori. Voglio organizzare visite e degustazioni, accogliere persone interessate. La curiosità è tanta, sia tra gli appassionati che tra chi lavora la terra.
Vedo molti giovani che si avvicinano a questa realtà. Dal punto di vista commerciale, c’è una forte domanda, soprattutto a Parigi, dove tanti hanno compreso il valore di coltivare viti senza trattamenti chimici, apprezzandone anche il gusto unico. Lavorare con questi vitigni è una meraviglia: non richiedono trattamenti.
Prendiamo ad esempio il nostro Chardonnay: quando viene trattato, emana un forte odore di zolfo. Anche una vigna biologica, trattata con zolfo e rame, lascia un odore persistente. Se saluti un vignaiolo bio con un bacio, senti l’odore di quei trattamenti per tutta l’estate. È un segno che resta, un’impronta sul vignaiolo stesso. Noi, invece, proponiamo piante che non lasciano questa traccia e vogliamo farle conoscere.
Le cose stanno cambiando: le denominazioni iniziano a consentire l’uso di alcuni vitigni ibridi, seppur in via sperimentale. Questo è un primo passo verso un futuro più sostenibile.

Le AOC e la tradizione
Le AOC, secondo me, sono fuori strada. C’è troppa inerzia. Il clima evolve più rapidamente delle AOC. Questo peso di una pseudo-tradizione... Per fortuna noi ci prendiamo 2-3 libertà con i “Vins de France” e guadagniamo tempo, perché questa storia della tradizione è davvero assurda.
Se penso, per esempio, alla bottiglia di vino: non è un recipiente tradizionale. Prima degli anni ’40, tutto il vino veniva venduto sfuso, la bottiglia costava troppo. Henri Maire – come racconta benissimo Pierre Overnoy – accettava bottiglie vuote in cambio di un chilo di patate. Perché la bottiglia era troppo cara. Di solito, una bottiglia di vetro costava più del vino che conteneva negli anni ’40. Quindi il vino era tutto sfuso. Quando si apriva una bottiglia chiusa con un tappo, era davvero una buona cuvée, ma era raro. Il tappo di sughero e la bottiglia esistono da molto tempo, ma non sono il recipiente tradizionale. Abbiamo 20 secoli di viticoltura in Jura, 2000 anni dai tempi dei Romani. In 2000 anni, solo 60 anni di uso della bottiglia.
Poi possiamo parlare dei vitigni: stessa cosa. Abbiamo 2000 anni di viticoltura. Per 2000 anni, le vigne non sono state trattate. Gli agricoltori prendevano una talea, staccavano un tralcio di vite per piantarlo, e nasceva una nuova pianta. Raccoglievano l’uva senza trattamenti. Per 2000 anni non si sono fatti trattamenti.
Quando parlo con vignaioli che mi dicono "oh, i tuoi nuovi vitigni", rispondo che mi sento iper-tradizionalista facendo viticoltura come si è sempre fatta, senza trattamenti. È ciò che è naturale. L’uso dei trattamenti è iniziato soprattutto negli anni ’70. Le AOC sono arrivate nel ’36, ma si può dire che intorno al ’50 hanno uniformato la composizione dei vitigni in Francia. Oggi ci sono 40 vitigni che rappresentano il 96% delle coltivazioni. Si coltivano 40 vitigni, mentre alcuni ampelografi dicono che esistono 20.000 specie di viti. Coltiviamo solo 40 di queste. Di questi, ci sono due categorie: vitigni sensibili e molto sensibili. Il savagnin è sensibile, lo chardonnay è molto sensibile. Siamo in difficoltà a causa di questa miseria genetica.
Ci servirebbe diversità. Bisognerebbe incrociare le varietà. Abbiamo un problema genetico: abbiamo selezionato campioni che non sono rustici, che non resistono e muoiono continuamente. Serve diversità.
Hanno standardizzato il vino come un prodotto agroalimentare, dicendo "questo è ossidato", "questo sa di topo", "questo ha sentori di riduzione". Senza chiedersi se tutto ciò non contribuisca al bouquet. È come una persona che ha sempre mangiato formaggi industriali e poi assaggia un formaggio artigianale: lo troverà puzzolente. Con il vino è lo stesso: lo hanno talmente “perfezionato” con solfiti e lieviti... Pierre Overnoy ha lottato contro tutto questo. Ora, quando si fa assaggiare un vino naturale a un degustatore qualificato, dirà: "No, frizza, non è filtrato, ha sentori di riduzione." Senza chiedersi se il vino non possa avere un bouquet autentico.
Faccio spesso paragoni tra vino e musica. Se hai voglia di ascoltare i Rammstein, non ascolterai Vivaldi o Michel Sardou. Secondo me, le AOC vogliono fare il Michel Sardou del vino. È tecnicamente ben fatto, con i migliori parolieri e arrangiatori per un prodotto impeccabile, ma privo di anima. Io preferisco dissonanze. C’era così tanta varietà, e hanno voluto uniformare tutto dicendo: "Questo è buono, questo no." Le AOC peggiorano sempre di più. Noi siamo usciti dalla denominazione, quindi non abbiamo più problemi. Vedo tanti giovani vignaioli che hanno assaggiato i miei vini e si sono ispirati. Ma il sistema è brutale. Un giovane affronta difficoltà con il clima, le prime bottiglie, non ricorre a meccanizzazione, perde 20 chili in una stagione, poi porta il vino alla commissione e viene umiliato con un: "Il suo prodotto danneggia la denominazione." Non può chiamarlo Côte du Jura. È molto complicato. L’ho vissuto anch’io. Ora sono più distaccato, ma per anni ho cercato di capire il sistema. Sono stato eletto nel mio sindacato della denominazione per discutere, ma ci sono due tipi di agricoltura incompatibili.
Non posso chiamare i miei vini savagnin, ad esempio. La denominazione ha definito i vitigni giurassiani: savagnin, trousseau, poulsard. Sono troppo rappresentativi dello Jura. Le autorità mi hanno detto: "Non si può fare un vin de France savagnin." Non posso scrivere “Jura" sull’etichetta. Posso fare un vin de France chardonnay, perché è ovunque, ma non un vin di France poulsard. Questa è la legislazione.
Hai smesso di usare il tappo di sughero?
Sì, nel 2018 ho avuto seri problemi con il sughero: bottiglie con sapore di tappo, altre che perdevano. Dovevamo rilavare tutte le bottiglie, e molte si sono rovinate proprio a causa del tappo. Così siamo passati al tappo a vite, e da allora non abbiamo più avuto problemi. Certo, abbiamo perso due o tre piccoli clienti, ma la serenità che abbiamo guadagnato non ha prezzo.
L’imbottigliamento è un momento molto stressante: ti chiedi se il vino continuerà a evolversi bene in bottiglia, se si ossiderà o avrà il sapore di tappo. Basta una bottiglia su dodici con difetti per rovinarti, perché vendi due cartoni e sai già che il cliente troverà una o due bottiglie difettose. Ora, invece, sono molto più tranquillo. So che non ci sono perdite o problemi di deviazione legati al sughero.
Abbiamo già abbastanza stress da gestire: il meteo, le fermentazioni, i pagamenti in ritardo. Eliminare almeno questa fonte di preoccupazione è stato un grande sollievo. Tornare al sughero? No, è fuori discussione.

E tuo figlio, ha sempre voluto fare il vignaiolo?
Ha iniziato il suo apprendistato qui, frequentando un diploma professionale di tre anni. Dopo è stato dipendente per un anno, e ora, da due anni, siamo soci. All’inizio, però, non era convinto, e questo è stato un po’ un problema, perché... per fare questo mestiere devi davvero avere una passione profonda. È un lavoro che amo, ma può essere ingrato.
Si ripetono sempre gli stessi gesti: la potatura, ad esempio, è lo stesso movimento ripetuto per tre mesi. Ora stiamo facendo innesti: tagli la pianta, la dividi e inserisci due gemme. E lo fai per tutto il giorno. A me piace moltissimo, ma non puoi vivere questo lavoro come una costrizione: devi amarlo. Jules, all’inizio, era titubante. Però, durante la scuola, ha scoperto la sua passione, e ora lavora con piacere. Ed è proprio questa la condizione essenziale: se non ami ciò che fai, non è possibile andare avanti.
Ma questo vale per ogni mestiere. Che tu sia insegnante o meccanico: se non hai passione, è un disastro. Un meccanico che non ama il suo lavoro sarà un pessimo meccanico. Un insegnante che non ama insegnare sarà un pessimo insegnante. Per fortuna, con Jules, le cose sono cambiate. Ora, molti suoi amici d’infanzia lavorano anche loro in vigna. All'inizio, sembrava quasi una moda, questo lato un po' hipster di fare vino naturale e tutto il resto. Lui pensava che fosse un mestiere da sempliciotti, ma non è così. Sono sicuro che, se dieci anni fa avessimo chiesto a questi giovani cosa volevano fare, pochi avrebbero risposto “il vignaiolo”. E invece, ora lavorano tutti nella vigna e sono soddisfatti del loro percorso.
Eventi sul vino ibridi
Hybride 2024
Le Salon des Débouchées 2024
Résistance : Le salon des vins hybrides
Articoli, interviste e libri su vino ibridi
Un autre vin, entretien avec Valentin Morel, Radio Vino (2023)
Le vin du futur, France Inter (2023)
Vitis Batardus Liberata, association des vins hybrides.
Mille Vignes, Penser le vin de demain, Pascaline Leperltier (2024)